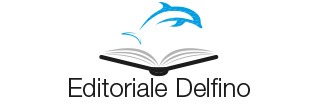Questa nuova legislazione, conforme alla direttiva UE, mira a promuovere la sostenibilità e l’accountability aziendale. Le imprese, guidate da standard come il Global Reporting Initiative, vedono questa normativa non solo come un obbligo, ma anche come un’opportunità per allineare i processi interni alle aspettative di mercato e accedere a finanziamenti agevolati. Un ruolo chiave è quello del Sustainability Manager, incaricato di implementare e monitorare la sostenibilità aziendale.
Anche in Italia, il concetto di sostenibilità entra nella nostra legislazione e diventa un obbligo per le aziende, a partire dal 2024 limitato ad alcune aziende in relazione alle dimensioni, e poi ne gli anni successivi i parametri si abbasseranno fino ad arrivare a tutte le società, in particolare il legislatore ha previsto l’obbligo per alcune determinate aziende di redigere la dichiarazione non finanziaria, in cui vengono elencate e misurate le azioni messe in atto per una crescita sostenibile e in accordo con i criteri ESG (Environmental, Social and Governance).
Nel preparare la documentazione non finanziaria, le imprese si rifanno a standard nazionali o internazionali identificati nel Global Reporting Initiative (GRI), ente senza scopo di lucro istituito per definire gli standard di rendicontazione della performance di qualunque organizzazione (sono organizzati in quattro serie che rispecchiano la suddivisione dei fattori ESG e di standard di livello più alto per la misurabilità della sostenibilità aziendale).
Tale normativa se da un lato viene vista dalle aziende come l’ennesimo fastidioso obbligo, dall’altro si ritiene che debba essere anche visto come fonte di opportunità, poiché tale processo porta in dote la capacità di comprendere in modo più approfondito se i propri processi interni siano allineati alle esigenze esterne ed al sentimento del mercato, e consente alle aziende stesse di avere un accesso al credito bancario agevolato, nonché risorse dalle istituzione pubbliche, in particolare il PNRR ha stanziato ingenti somme a tale scopo.
Formare figure professionali interne o esterne quali il SUSTAINABILITY MANAGER che si occupa di applicare e monitorare la sostenibilità, in particolare, lavora sull’innovazione e sul trasmettere l’importanza di una cultura della sostenibilità nelle aziende, a tutti i dipendenti. Tali processi dovranno essere poi rendicontati e attestati da un Revisore specializzato, in particolare: Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), disciplina infatti anche le modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e modifica la disciplina recata dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Il Decreto, stabilisce che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di attestazione a cura di un revisore, il cosiddetto “revisore della sostenibilità”, abilitato ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e appositamente incaricato di esprimere con la relazione di cui all’art. 14-bis del d.lgs. 39/2010, le proprie conclusioni circa la conformità:
– della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
– all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 3, comma 10, e all’art. 4, comma 9;
– all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Il Decreto stabilisce inoltre che le conclusioni della relazione di attestazione sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all’adozione da parte della Commissione europea dell’atto delegato di cui all’art. 26- bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE, l’incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.
Cosa si intende per sostenibilità aziendale
È la capacità di un’azienda di perseguire nel tempo il proprio successo economico, sociale e ambientale senza compromettere risorse ed equilibri a lungo termine. Le aziende sostenibili sono, quindi, soggetti attivi nel processo di cambiamento per limitare i danni sull’ambiente, mediante azioni che tengono in conto le conseguenze nel lungo periodo, evitando danni all’ambiente o alla società e realizzando condizioni migliori per la vita.
La normativa (ESG) definisce tre dimensioni della sostenibilità:
– AMBIENTALE: primo elemento considerato, perché l’inquinamento atmosferico terreste e delle acque, derivanti dai cicli produttivi aziendali, impatta in modo significativo. Si tratta, quindi, di arginare l’impatto e sviluppare tecnologie per rendere gli impianti più efficienti, investire in fonti rinnovabili, ed implementare cicli produttivi che rispettino ambiente
– SOCIALE: hanno a che vedere con il modo in cui l’impresa si relaziona con il tessuto sociale in cui opera, si concretizza nelle politiche aziendali interne, quali uguaglianza, parità di genere, rispetto dei diritti, sicurezza e creazione di un ambiente sicuro sul posto di lavoro, il benessere delle persone che lavorano in azienda, si può rivolgere anche all’esterno, con attività filantropiche o sostenendo attività per fasce di popolazione meno fortunate con il volontariato ed altre iniziative che portano benessere al tessuto sociale.
– ECONOMICA: in generale attiene alla cosiddetta Governance, definita come la modalità di amministrare e all’etica delle decisioni prese, una impresa sostenibile è una azienda in grado di produrre valore per la collettività, per l’intera organizzazione e in generale per gli Stakeholders, ossia tutti coloro che hanno un interesse diretto o indiretto nell’azienda, generando profitto in modo etico, in altri termini la capacità di ottenere profitto e di generare valore nel tempo, producendo beni che possano migliorare la vita delle persone.
Pertanto è un processo che penetra tutti i livelli aziendali e che necessitano attività di report adeguati, uno di questi è il bilancio di sostenibilità, un documento che fornisce dettagli su azioni intraprese, impatti e progresso verso determinati obiettivi. La redazione del bilancio, però, richiede parametri di riferimento, tra cui gli standard GRI (linee guida internazionali per le performance sostenibili) e gli ESG- environmental social and governance (tre elementi che sono i criteri per valutare prestazioni sostenibili e etiche di un’azienda/ investimento).
Un report EY “Seize the Change Futuri Sostenibili”, condotto su 300 aziende italiane, ha mostrato che il 69% di esse ha sviluppato già un piano di sostenibilità aziendale. Solo, però, il 35% ne ha già definite le tempistiche, mentre il 15% che ancora non ha un piano vuole prevederne uno sviluppo in futuro. Per spronarne l’adozione, il 37% dei fondi del PNRR è stato destinato alla rivoluzione verde e transizione ecologica. L’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 paese aderenti all’ONU: qui si indicano i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030 per salvaguardare persone e Pianeta.
Tra gli obiettivi ci sono eliminazione della fame, lotta alla povertà e alle disuguaglianze e contrasto al cambiamento climatico. Il conflitto in Ucraina, però, ha costretto molto paesi come l’Italia a trovare nuove alternative energetiche, rallentando il processo di sostenibilità aziendale ma comunque accelerando la conversione verso fonti rinnovabili e sostenibili. Inoltre, l’impennata dei costi delle materie prime ha reso evidente come l’economia circolare delle materie secondarie sia strategica alla transizione ecologica. In conclusione, possiamo affermare che per i settori che si occupano di Energia, tecnologia possa rappresentare una valida opportunità di crescita e di entrare, ancor di più nel ciclo economico-produttivo aziendale.
Aspetti tecnici
Per misurare l’impatto ambientale vengono utilizzati come indicatori di sostenibilità: le emissioni di gas serra, il consumo di acqua, la gestione dei rifiuti, la sicurezza dei prodotti, l’impatto sociale sulla comunità ed altri parametri correlati. Importanza viene data alla provenienza di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, come già richiesto nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) si prediligono quelli provenienti da lavorazioni in cui siano rispettati diritti civili, norme sulla sicurezza del lavoro, ed altri diritti riconosciuti universali. Gli ESG coinvolgono tutti i settori produttivi, in particolare: Energetico, finanziario, manifatturiero, tecnologico, immobiliare ecc.
Articolo a cura di Michele Di Lena, Egidio Fortunato, Francesco P. Lamacchia e Antonio Padula.